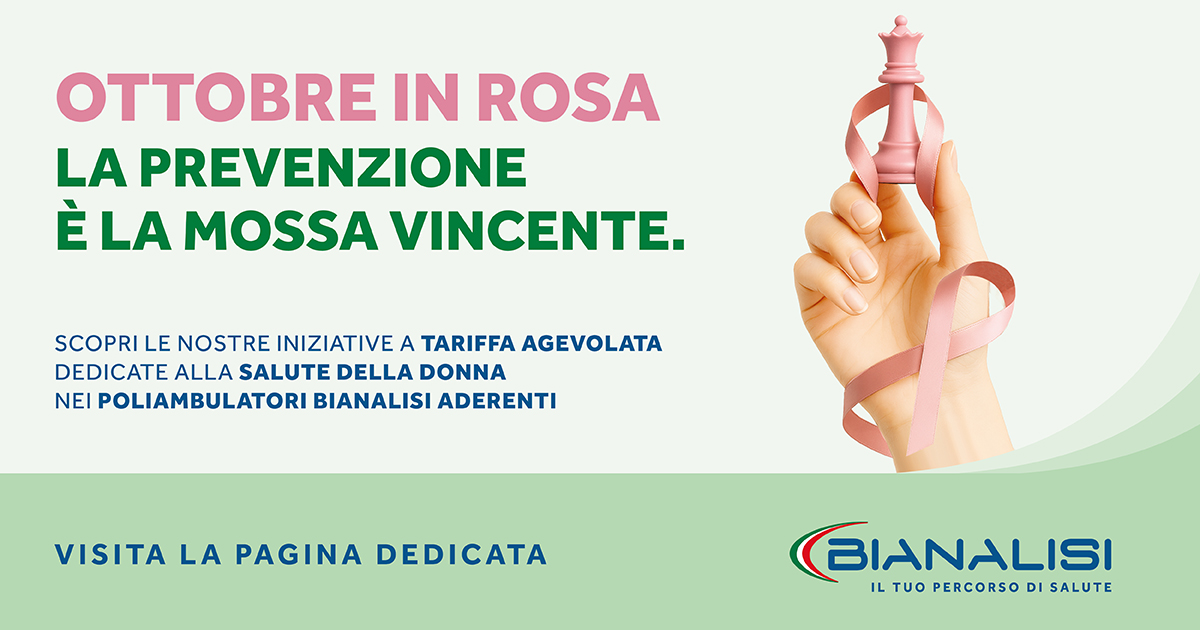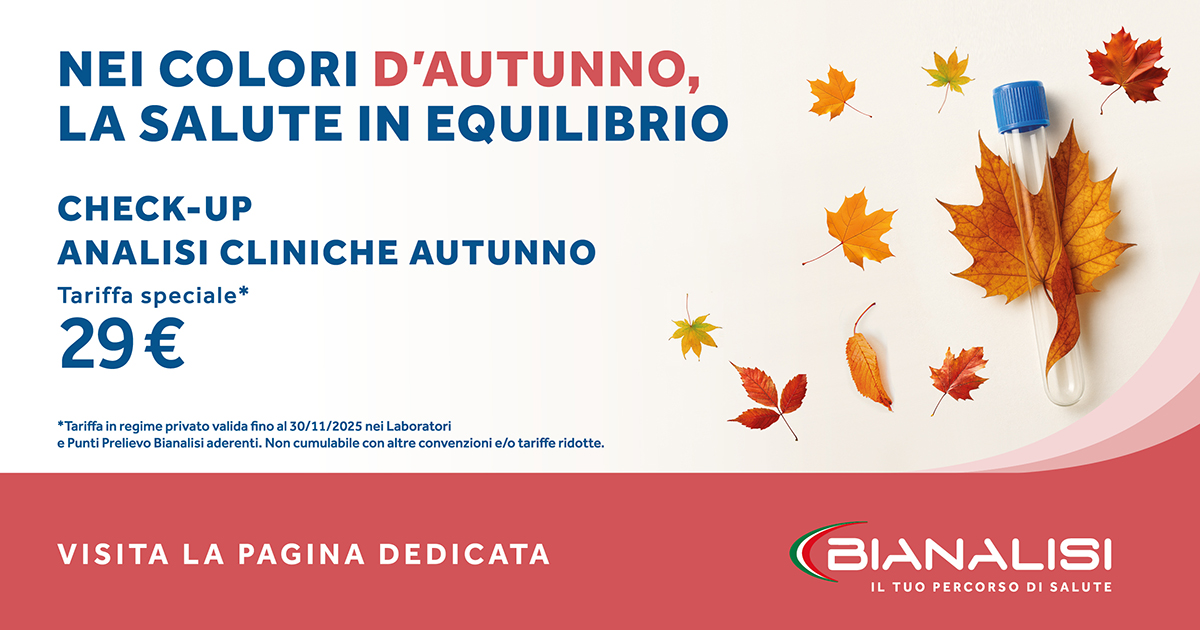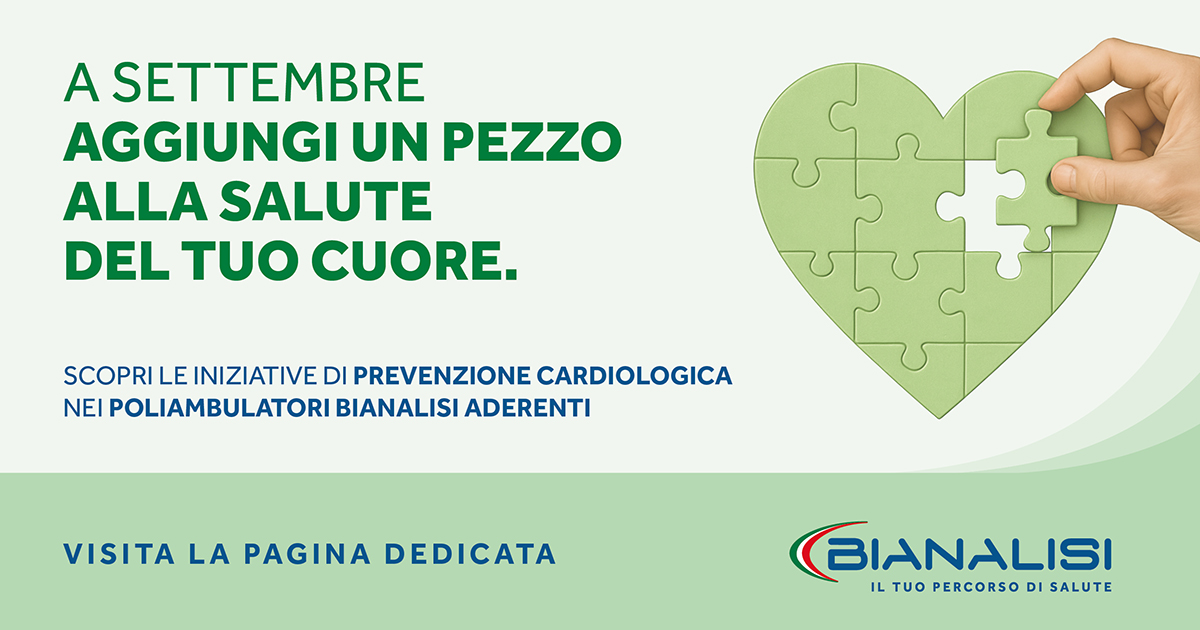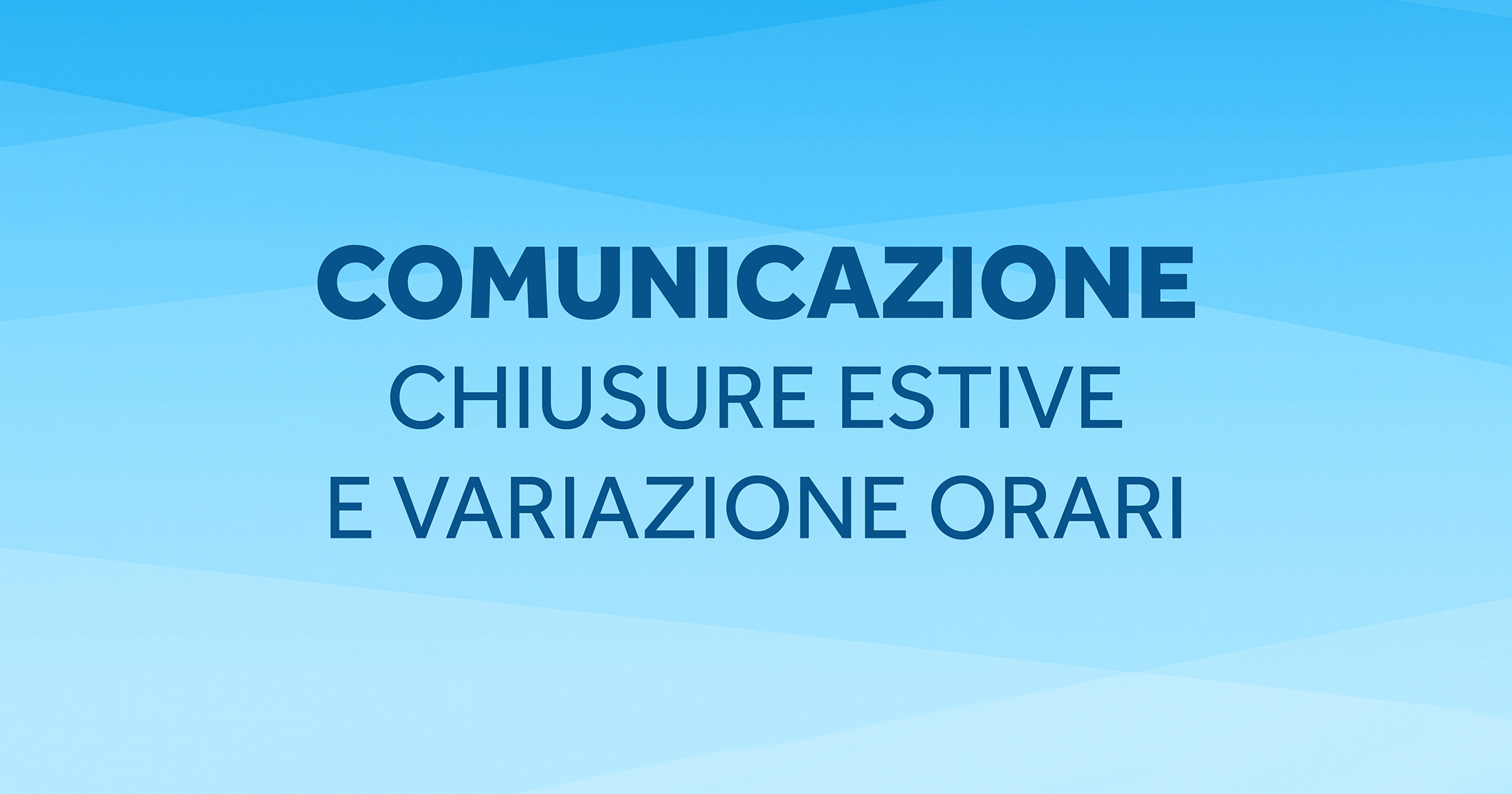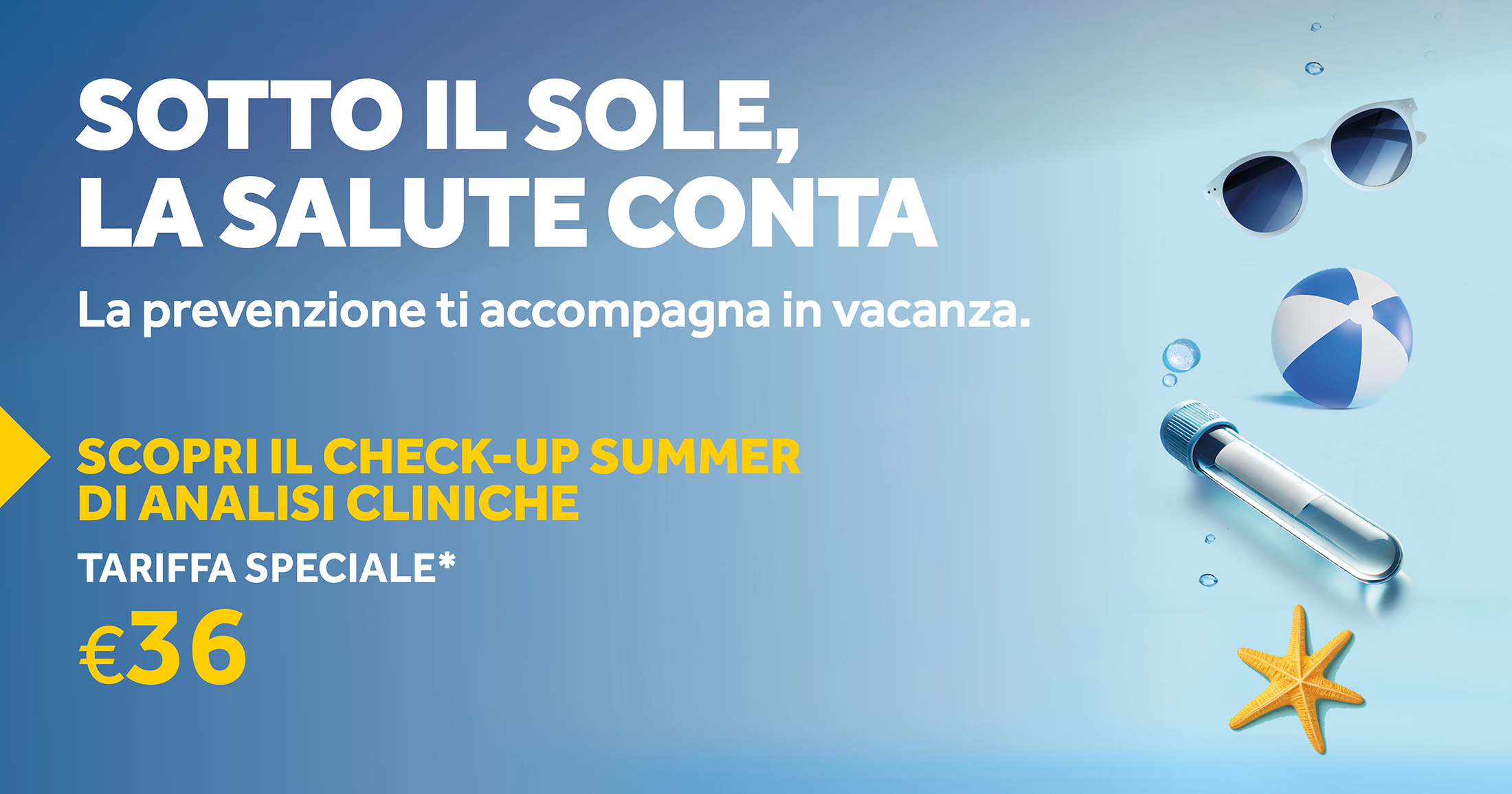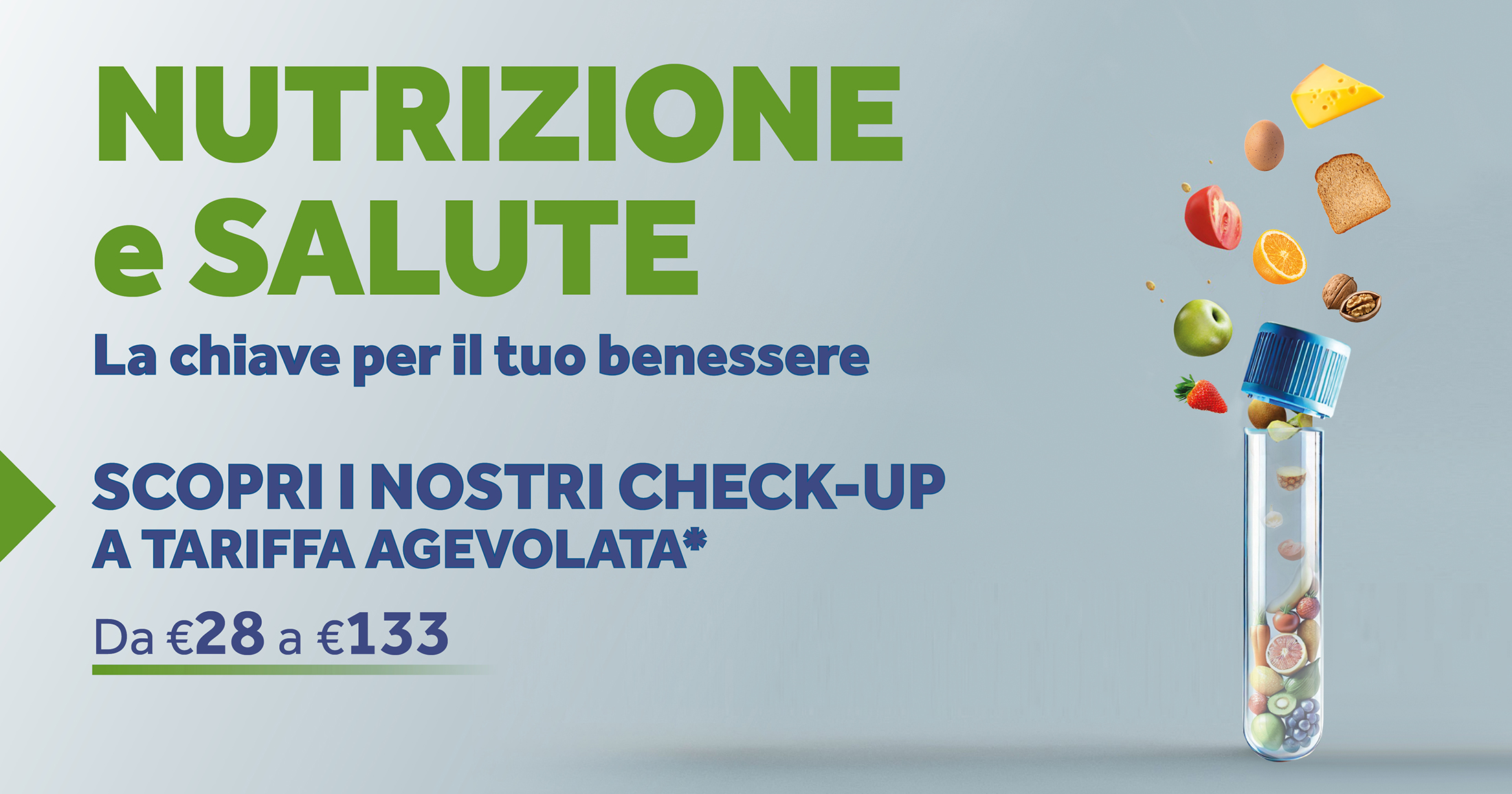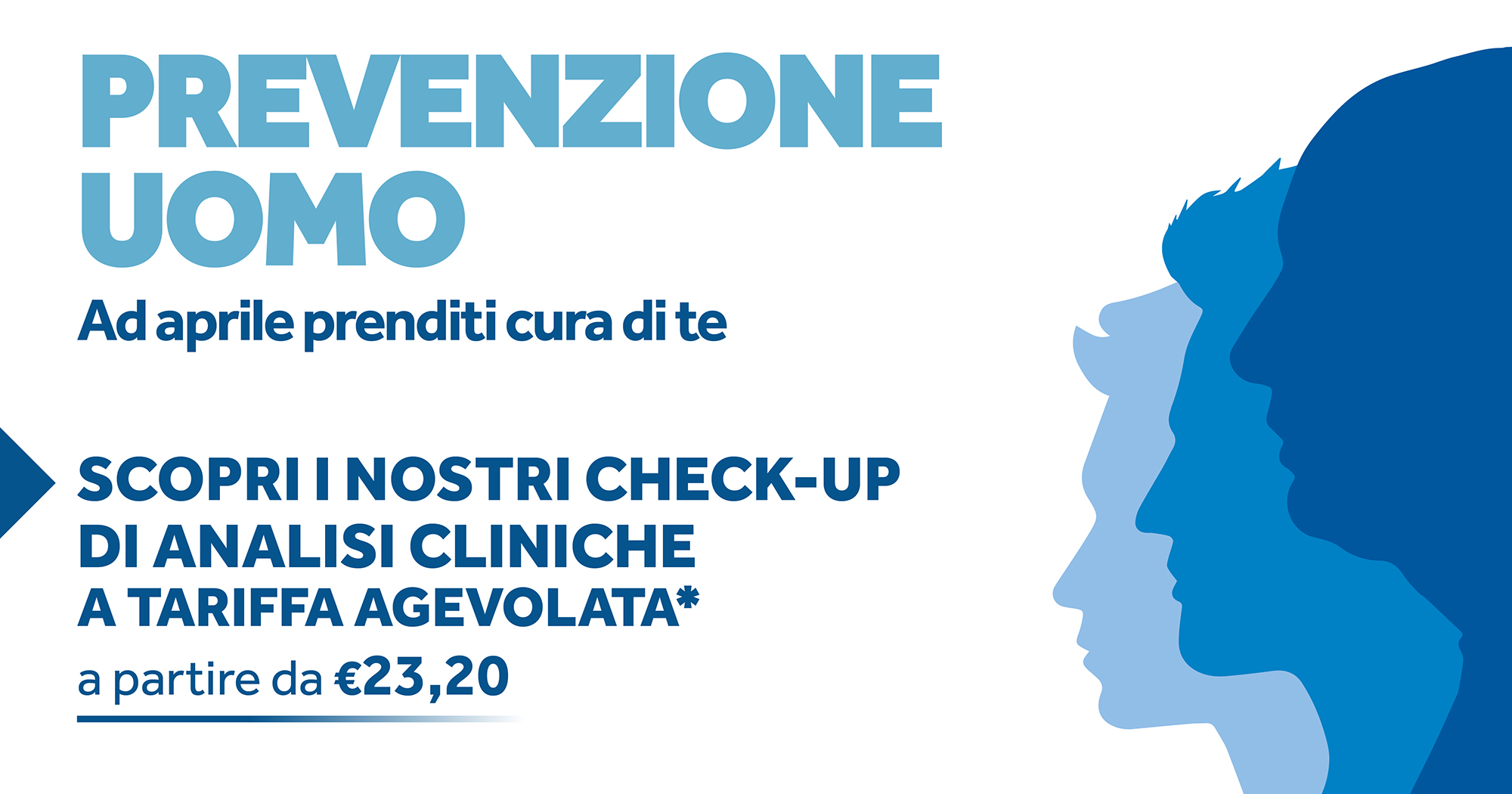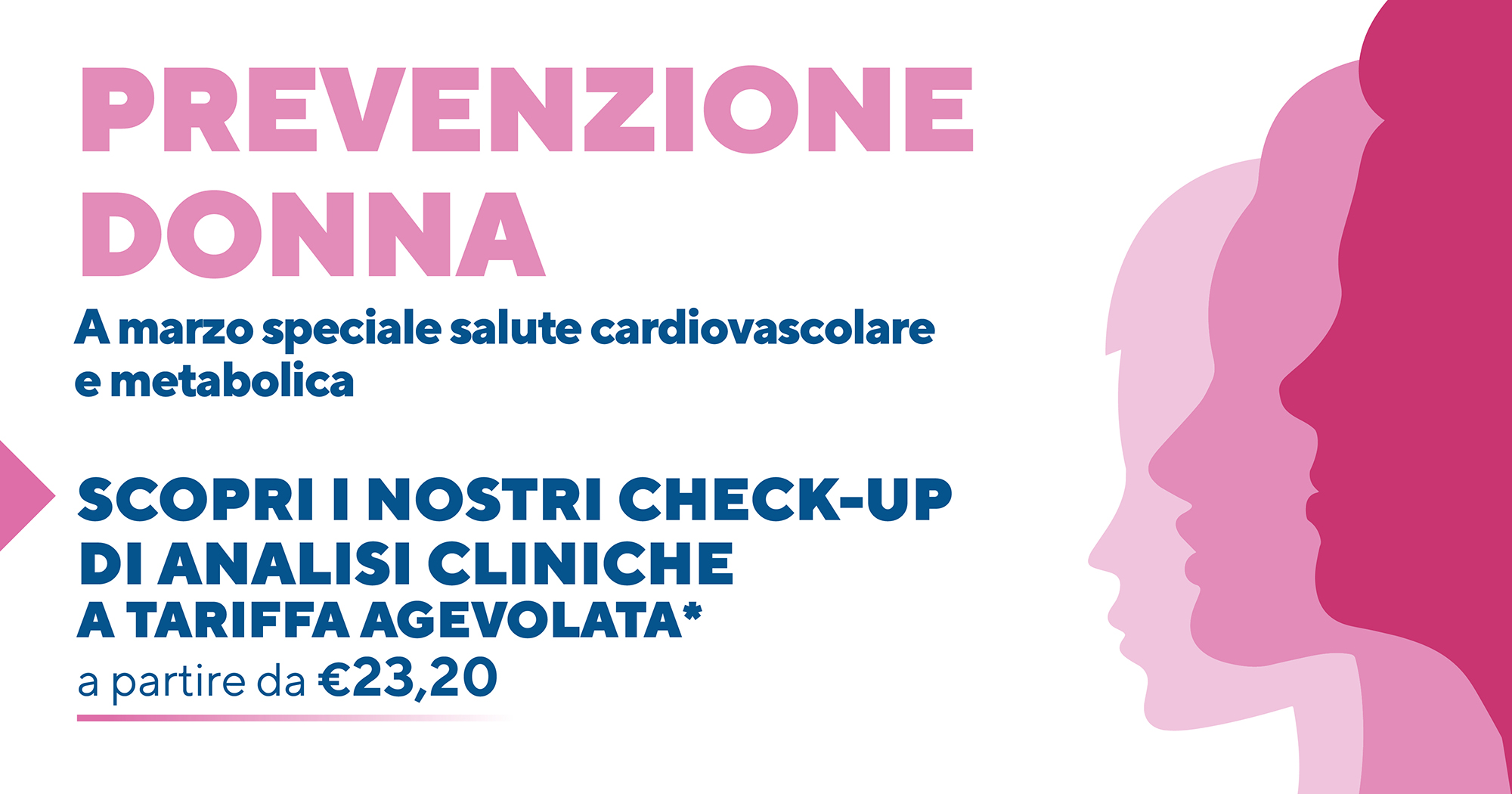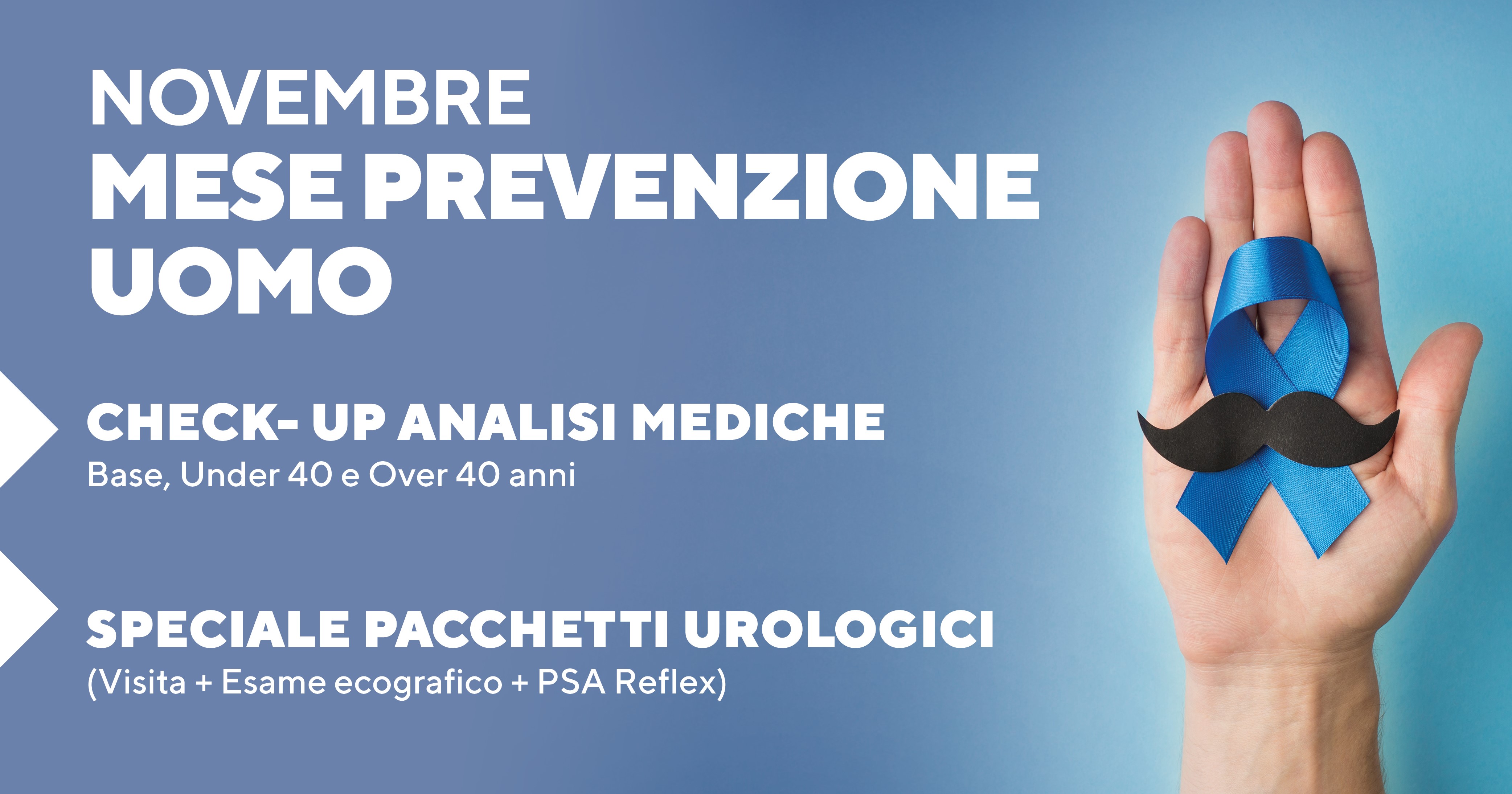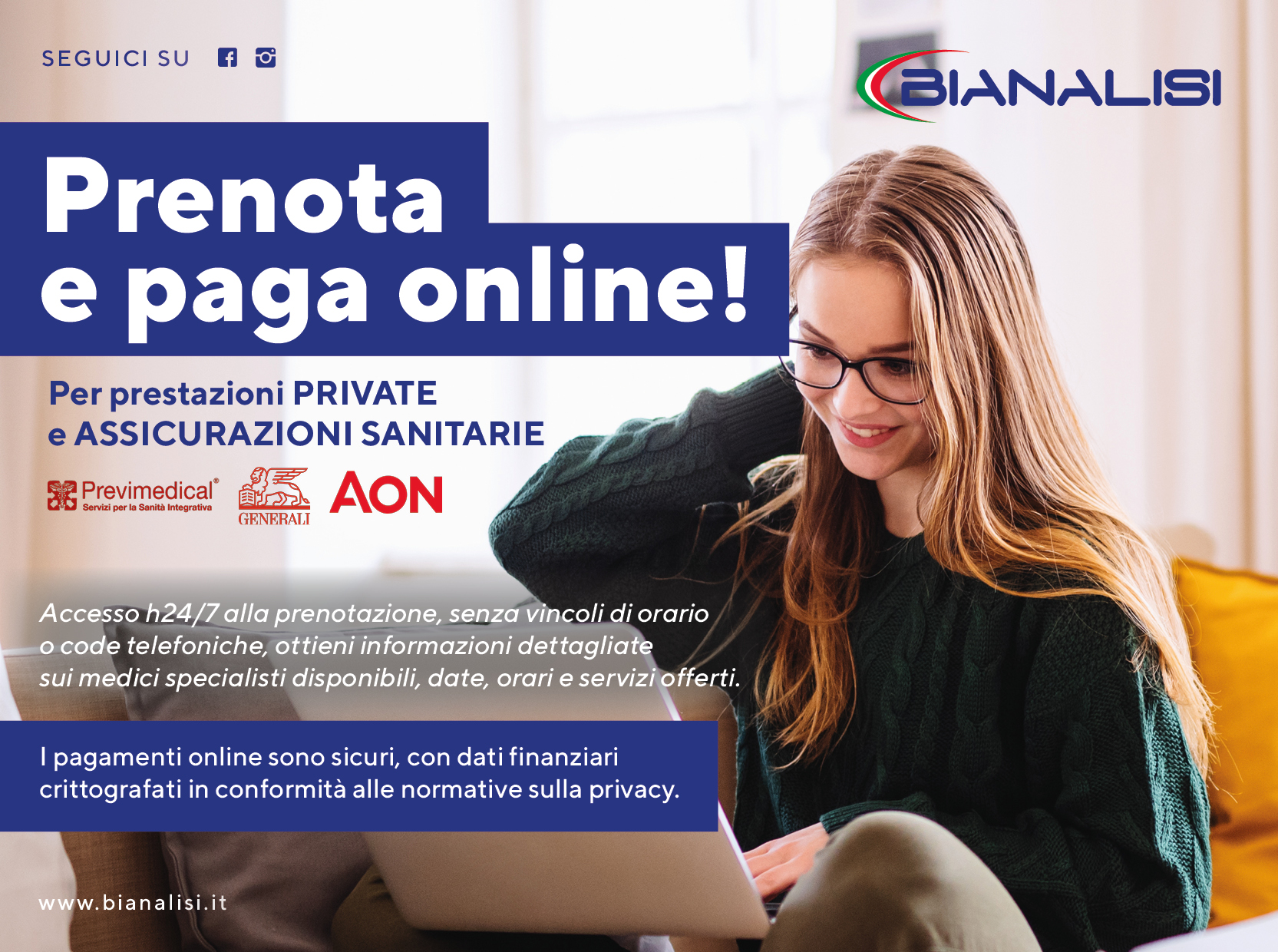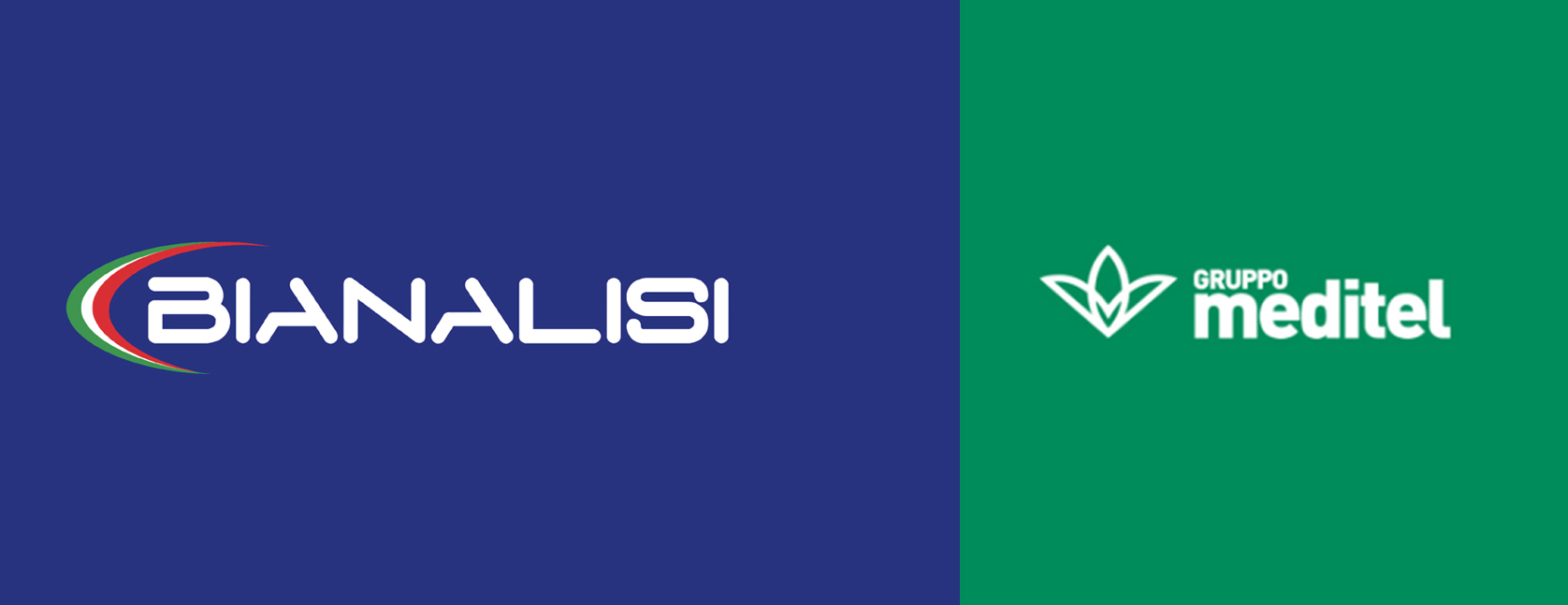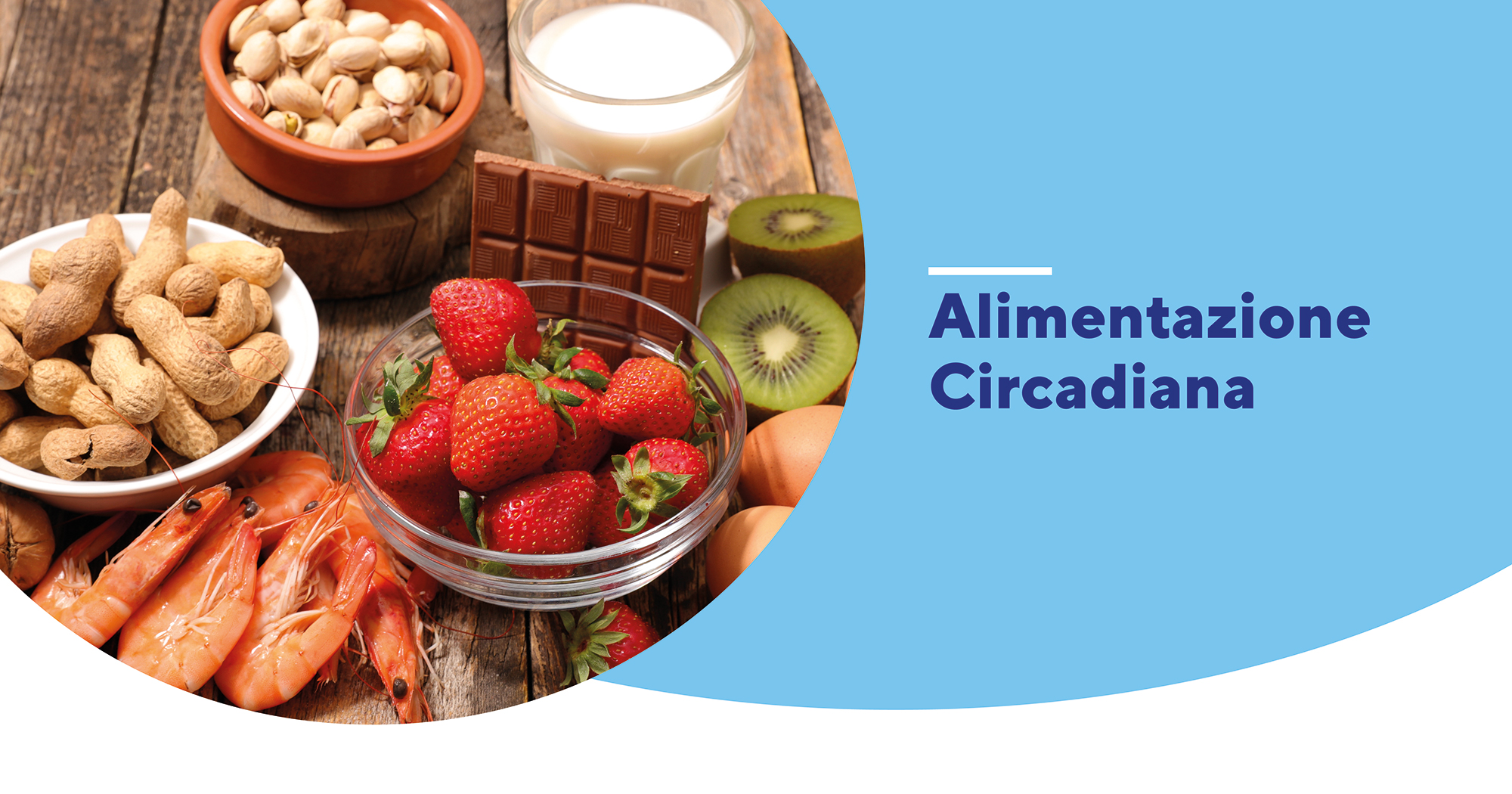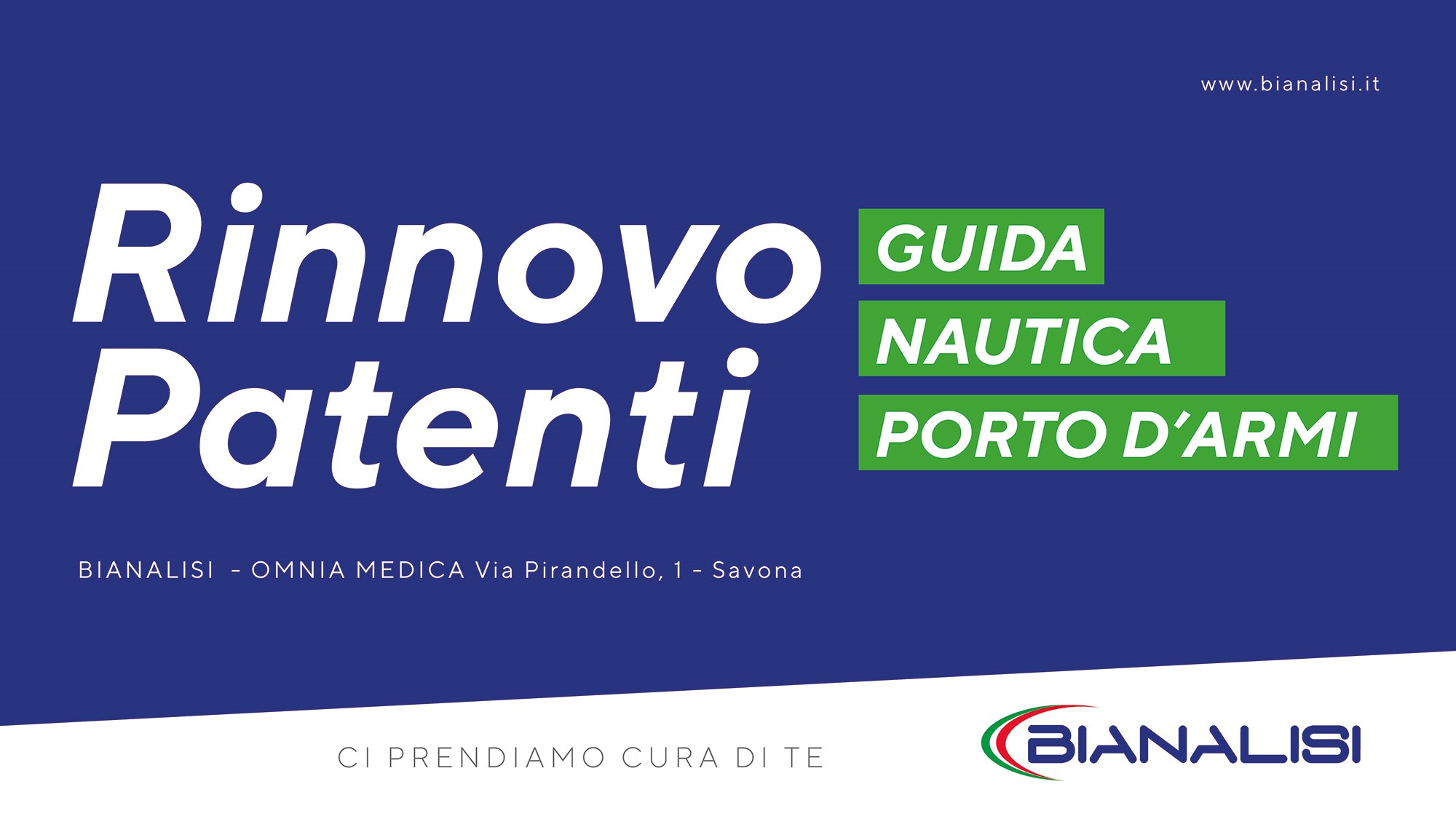24-06-2025
Redazione Bianalisi
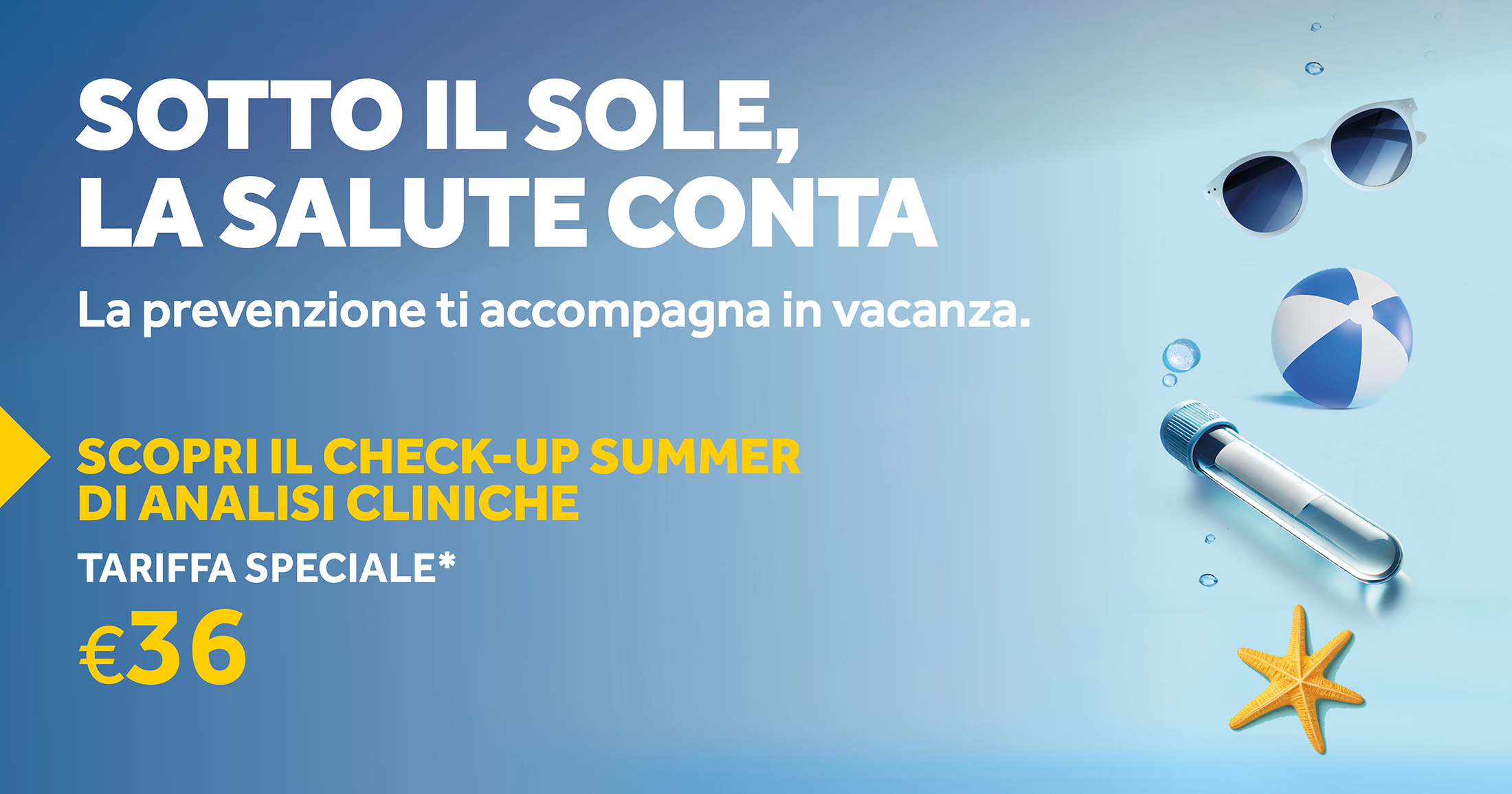
La prevenzione ti accompagna in vacanza!
L’estate è il momento perfetto per rilassarsi, ma anche per prendersi cura della propria salute. Con il Check-up Summer Bianalisi puoi monitorare il tuo stato di benessere in modo semplice, veloce e ad una tariffa speciale € 36*
Test inclusi:
Sodio, Potassio, Magnesio, Fosforo, Creatinina, Azotemia, Esame urine
Colesterolo Totale, HDL, LDL, Trigliceridi, Glicemia, Uricemia
GOT, GPT, GammaGT, LDH
Sideremia, Emocromo, Elettroforesi, Proteine Totali, Vitamina D
Perché farlo:
Idratazione e sali mineraliControlla come il tuo corpo reagisce al caldo e previeni disidratazione e squilibri elettrolitici.
Metabolismo e salute cardiovascolareTieni sotto controllo colesterolo, trigliceridi e glicemia per un’estate in salute.
Fegato e muscoliMonitora eventuali affaticamenti da stress, dieta irregolare o attività fisica intensa.
Ferro, proteine e Vitamina DControlla eventuali carenze nutrizionali anche nei mesi estivi.
Disponibilità e prenotazione:Il Check-up Summer è disponibile nei Laboratori e Punti Prelievo Bianalisi aderenti, senza necessità di prenotazione (ad eccezione di alcune strutture) per tutte le info clicca QUI
*Tariffa valida solo in regime privato fino al 27/09/25 nei Laboratori e Punti Prelievo Bianalisi aderenti. Non cumulabile con altre convenzioni o tariffe ridotte.
È importante consultare un professionista per interpretare i risultati.
Leggi Articolo